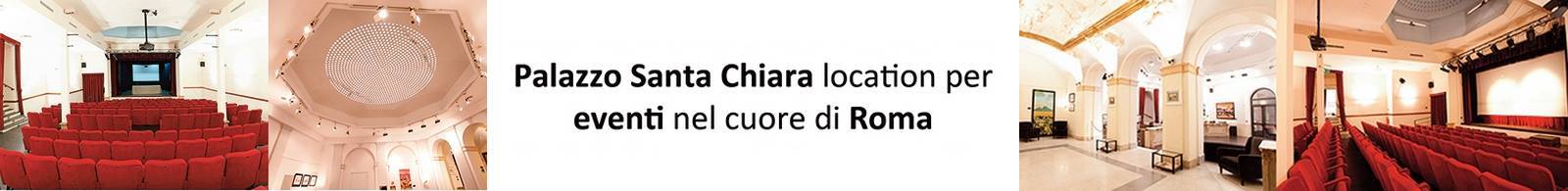OGGI QUATTRO ANNI FA
Il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 – attuativo del decreto legge n. 14 emanato in pari data – fa giustizia di una serie di ambiguità che hanno caratterizzato la presentazione mediatica dell’infezione da coronavirus e favorisce, oltre che la riduzione della diffusione dell’infezione, una più realistica presa d’atto da parte dei cittadini della vera natura del coronavirus e dei gravissimi rischi di una sua diffusione epidemica.
Risultano in particolare clamorosamente smentite le rassicuranti affermazioni di alcuni esperti che definivano «poco più che un’influenza» l’infezione stessa. Resta ancora da sfatare la singolare e interessante teoria, pure uscita dal circolo degli esperti, in base alla quale non si muore «per» coronavirus, cioè a causa dell’infezione virale, ma «con» il coronavirus, cioè in compagnia di un ospite tutto sommato non così crudele come viene descritto; la causa della morte sarebbe essenzialmente rappresentata dall’età dei pazienti e dalle malattie o acciacchi da cui erano affetti.
A uccidere il paziente non sarebbe dunque il dimostrato e spesso fatale coinvolgimento polmonare da parte del processo morboso, ma il diabete, l’ipertensione, la ridotta difesa immunitaria eccetera, che già minavano la salute del paziente. Il messaggio sottostante ma abbastanza trasparente e tranquillizzante da parte di alcuni esperti – accompagnato da reiterate espressioni di rammarico e di anticipato cordoglio – è che si tratta in fondo di pazienti anziani (l’età media dei deceduti è di ottantuno anni) la cui morte, tutto sommato, potrebbe essere considerata «già in corso».
Il problema principale non è tanto rappresentato dal decesso degli attempati infermi quanto dall’intasamento dei reparti di rianimazione presi d’assalto da una inusuale massa di pazienti gravi, che mette in crisi il nostro glorioso ma già traballante servizio sanitario nazionale e impedisce l’assistenza e la cura di coloro che sono costretti a rivolgersi agli ospedali perché colpiti da affezioni pure gravissime, ma di più tradizionale riscontro.
Una serie di considerazioni sulle particolarità del quadro clinico dell’infezione da coronavirus e sulle circostanze dei decessi fa sorgere tuttavia seri dubbi sulla attendibilità di una tale tesi che appare fin troppo rassicurante, fino a sfiorare il sospetto di un cinismo di cui, in verità, si stenta a prendere atto. Considerato che la infezione da coronavirus e l’influenza stagionale colpiscono strati omogenei di popolazione, sembrerebbe abbastanza chiaro dalle storie cliniche fin qui diffuse dai media che la maggiore gravità del decorso e il più elevato tasso di mortalità della malattia da coronavirus rispetto a quello dell’influenza stagionale (il decesso avviene nel 20-30 per mille dei colpiti dalla infezione da coronavirus e solo nell’uno per mille dei colpiti da influenza stagionale) siano dovuti proprio alla maggiore frequenza e gravità del coinvolgimento polmonare nella infezione da coronavirus.
Inoltre la polmonite in corso di influenza stagionale, che con una certa frequenza può causare la morte nelle persone anziane, non è generalmente dovuta al virus influenzale, ma al sopravvenire per molteplici ragioni di una complicanza batterica, mentre quella da coronavirus è provocata proprio dal coronavirus in persona che scatena una violenta reazione da parte del sistema immunitario e dà luogo ad una «polmonite interstiziale», la quale con meccanismi diversi riduce l’assunzione di ossigeno a livello polmonare con conseguente diminuzione dell’ossigeno nel sangue e quindi nei tessuti e negli organi vitali fino a richiedere la somministrazione di ossigeno e il ricovero in reparti di rianimazione.
Non sembra esserci alcun dubbio che tutto ciò sia dovuto ad un «effetto grilletto» dell’infezione da coronavirus e che, ad oggi, potrebbe essere evitato soltanto impedendo il contatto coronavirus-uomo. Non è superfluo ricordare che, se è vero che la malattia è letale soprattutto nelle persone piuttosto avanti negli anni, è anche vero che il 22 per cento dei colpiti ha tra i diciannove e i cinquanta anni (dati dell’istituto superiore di sanità). Si tratta di pazienti non esenti da forme gravi che richiedono il ricovero in ospedale e da forme gravissime che impongono il ricovero in reparti di rianimazione. Dal bollettino Covid-19 diramato dalla protezione civile alle ore 18 del 10 marzo 2020 risulta infatti che sul totale di 10.149 pazienti 5.038, pari a circa il 50 per cento, erano ricoverati con sintomi e 827, pari a circa l’8 per cento, erano ricoverati in terapia intensiva, mentre i deceduti erano 631, pari a circa il 6 per cento.
Una conferma viene dal fatto che il «paziente uno» di Codogno, un manager trentottenne ricoverato presso l’ospedale San Matteo di Pavia, solo dopo una quindicina di giorni di degenza nel reparto rianimazione è stato in grado di respirare autonomamente consentendo il trasferimento in un reparto di terapia subintensiva.
Dobbiamo infine osservare che nel disordinato dibattito mediatico in corso si è finora parlato troppo poco del ruolo decisivo del coinvolgimento polmonare nelle forme più sfavorevoli della infezione da coronavirus e dell’innegabile significatività dei reperti dell’imaging radiologico e, in particolare, dei reperti autoptici nei pazienti deceduti, il cui numero basterebbe ormai a definire meglio i vari aspetti e passaggi di un processo morboso che presenta inquietanti caratteri di gravità.
Una più puntuale e realistica informazione dell’opinione pubblica su questi aspetti non secondari favorirebbe una più consapevole accettazione delle giuste regole di comportamento adottate e pubblicizzate che, se messe scrupolosamente in atto, consentono di interrompere la catena di trasmissione del virus e di ridurre in maniera rilevante la diffusione del contagio e le sue nefaste conseguenze.
Girolamo Digilio
Nella foto: una immagine di Castiglione d’Adda